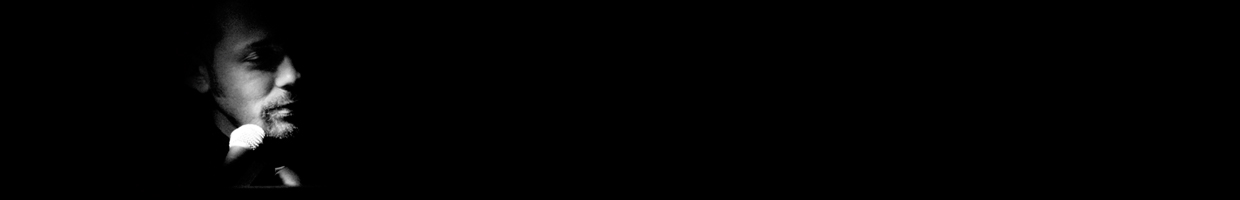Intervista a Renzo Cremona, un abitatore della lingua
di Eufemia Griffo
– Presentati brevemente, indicando anche il tuo blog, se ne usi uno per pubblicare.
Qualche anno fa è stato detto che abito la lingua. Credo che questa definizione racconti molto di me, ed è così che anch’io mi definirei adesso: un abitatore della lingua. Negli anni ho studiato cinese antico e moderno, neogreco, portoghese e georgiano all’Università di Venezia, e lavoro da tempo come insegnante di lingua e cività cinese e consulente linguistico. Mi piace occuparmi di lingue un po’, diciamo, “laterali”, e ho la vocazione del salvatore di idiomi in estinzione o già trapassati. In alcuni di questi – romancio e latino – ho pure composto e pubblicato. Leggere, scrivere, vedere, ascoltare e parlare una lingua – anche la nostra – è un’esperienza sensoriale e spirituale a trecentosessanta gradi, perché in quel momento si ha il privilegio di dimorare dentro un altro luogo: il luogo dove la lingua crea e disfa, dove tutto è possibile.
Della mia produzione come autore è possibile reperire qualcosa sul mio sito internet ufficiale (renzocremona.it), dove tra l’altro si fa menzione ai reading e ai recital dal vivo e anche ad alcuni miei lavori in qualità di traduttore. Le piattaforme che vengono però aggiornate con frequenza quasi quotidiana da me o dai miei collaboratori sono la mia pagina Facebook (facebook.com/renzocremona.official) e il mio profilo Instagram (renzocremonabooks). Una parte della mia produzione – quella dichiaratamente poetica – è ospitata dal portale di Italian Poetry (italian-poetry.org/poeti).
– Quando hai iniziato a scrivere, cosa ti ha spinto e perché?
Ho cominciato a scrivere prestissimo, quando ero ancora un ragazzino. Fu in occasione di una delle scorribande con un gruppo di bambini del mio condominio che mi venne l’idea di disegnare delle mappe dei campi dove andavamo a giocare. Mi divertivo a dividerle in diverse sfere di appartenenza, i “nostri” territori e quelli degli “altri” – i bambini dei condomini vicini – che ben presto diventarono di nessuno, perché non tardai molto a scoprire cosa davvero mi avesse tanto attratto in questo strano lavoro di cartografo precoce: scrivere sugli spazi vuoti della pagina un certo numero di parole che in un luogo si dicevano in un modo e, cento metri più in là, immaginavo che si dicessero in un altro. Non sapevo ancora cosa fossero le isoglosse né a cosa servissero, ma già trovavo irresistibile tracciare una geografia delle parole che andavo inventando di sana pianta. Il passo successivo fu quello di concepire dei documenti a pezzi dai quali mancavano alcune parole o frammenti di frasi: mi piaceva far finta che fossero stati ritrovati tra qualche rovina e che si dovesse decifrarne il senso. Non partivo dal significato. Quando scrivevo, il punto di partenza erano le parole inventate: solo dopo giocavo a dar loro un significato. Ecco. E così fu la lingua. Anzi, furono le lingue. Molteplici, tante, smisurate, e soprattutto belle. Solo qualche anno più tardi le parole si trasformarono in poesie e poi in qualcos’altro.
– Che genere di poesia scrivi? Se più di uno, in quale pensi di riuscire ad esprimerti meglio?
Il genere di scrittura che sento più affine è quella breve. Anzi, brevissima. In Foreste sensoriali (1993), la mia prima raccolta edita, difficilmente si troveranno testi lunghi più di qualche verso. Ai primordi tendevo ad amare soprattutto la lapidarietà e la folgorazione, poi è venuta anche la passione per il testo magmatico e sensuale – ma si trattava di età, credo. Alle superiori provavo una vera e propria adorazione per i lirici greci – forse proprio perché erano per la gran parte dei frammenti, mi è venuto da pensare in seguito riflettendoci, e portavano con sé la fascinazione che ha il perduto per sempre, quello che è stato recuperato per un puro accidente della sorte, il non detto più ancora del detto – ma la mia vocazione da viaggiatore ed esploratore mi aveva già fatto scoprire quel pochissimo che si riusciva all’epoca a trovare tradotto di poesia classica cinese e giapponese, e quello sì che è stato un incontro indimenticabile. Tra gli amori a prima vista in [semi]tenera età ne ricordo in questo momento due in particolare: quello con lo haiku e quello con la poesia tedesca del Novecento – Kunze su tutti, ma anche Brecht, Kunert e altri. Da allora non ci siamo più lasciati e torno a frequentarli intensamente di quando in quando. Poi è arrivata la parola greca di Nikos Chuliaràs, uno scrittore che è stato anche un grandissimo pittore, poeta e cantante: di lui amo tutto e ho letto tutto. Adoro i suoi quadri e la sua musica. Quando gli ho dedicato la testi di laurea, dieci anni fa, traducendo interamente in italiano due sue raccolte poetiche, mi ha persino chiamato da Atene per ringraziarmi degli haiku scritti in neogreco e ispirati alle sue atmosfere che gli avevo inviato assieme a una copia della tesi: ero sotto shock. Come se mi avesse chiamato Italo Calvino in persona! Difficile definire la sua produzione, che parla di una Grecia nascosta e ombrosa, inquietante, in bianco e nero… Ma è stato lui a imprimere una svolta nella mia scrittura. Devo a Nikos Chuliaràs il coraggio di avere intrapreso una strada che mi era decisamente più congeniale: quella della micronarrazione, del racconto quasi molecolare. Poi, certo, ognuno ha i propri temi e il proprio stile – o i propri stili, a seconda di ciò che scrive e di quando lo scrive – per cui la mia parola è piuttosto distante per ascendenza da quella del suo Epiro, e per alcuni potrebbe assomigliare di più alle cosiddette prose poetiche degli anni Venti, anche se secondo me con quelle c’entra ben poco. Da quindici anni, ormai, se eccettuo la produzione in forma haiku e quella teatrale – inaugurata ufficialmente nel 2015 con Fossa Clodia – la mia scrittura è questa: un genere che all’orecchio sembra poesia, ma all’occhio è inequivocabilmente prosa. Basta spezzare un discorso in prosa e metterlo in versi perché diventi poesia? Io non credo, ma è quello che ho visto fare a molti. E non basta neppure eliminare il verso fisico e virare verso la cosiddetta narrativa perché si elimini con quello anche il ritmo e la luce magica che promana da un testo squisitamente poetico. La scrittura è come la vita: dentro c’è tutto, e questo tutto è indiviso. Nonché indivisibile. Non c’entra nulla con l’ibrido del né-carne-né-pesce, la scrittura è totale. È questa scrittura di confine, quindi, che sento più vicina a me: ha una forma che sfugge alle classificazioni note e, come ha detto Stefania La Via nel 2010 quando mi ha presentato a Trapani durante un – per me – indimenticabile appuntamento della splendida rassegna curata da lei e da Ornella Fulco, Terrazza d’Autore, “è contraddistinta da un’incantata sospensione metafisica in grado di trasfigurare, grazie alla luce della parola, luoghi e situazioni che vibrano così di una nostalgia sottile e quasi antica”. È facile immaginarsi l’imbarazzo di qualche giurato ai premi letterari: cos’è questa roba? Prosa? Poesia? Mah. Pensa che lo stesso identico libro ha vinto una volta tra la poesia e un’altra nella prosa. Qualcuno è stato quasi irritato, addirittura. Io, invece, perplesso. Non ammiriamo forse un dipinto pur non sapendo il nome dell’artista o della corrente a cui viene ascritto?
– Il tuo lavoro è influenzato/ispirato da qualche poeta del passato? Se sì, chi è e in che modo ti influenza/ispira?
Noi siamo il frutto di molte cose: della biologia, innanzitutto. Ma anche dell’ambiente, certo. E con ambiente intendiamo non solo la famiglia e le persone che sono attorno e con noi, ma anche quelle che conosciamo attraverso la parola scritta, nei mondi che da questa sono continuamente creati. Ognuno di noi è la combinazione irripetibile di influenze diverse. E quanto più ci si addentra nell’esplorazione, tanto meglio è: si eviterà di ripetere quanto già sentito e letto. Quanto più si viaggia, tanto più la nostra scrittura assomiglierà a noi soltanto. Gli echi, poi, quelli sono dovuti al fatto che siamo esseri umani e in quanto tali sentiamo e viviamo come tanti altri prima e dopo di noi. Ma anche immaginando due autori con le stesse identiche esperienze di lettura condotte alla stessa identica età – e già questo caso diventa arduo da trovare – questi saranno di necessità diversi tra loro per come avranno reagito a queste influenze e per come le avranno rielaborate, per le strade che quelle avranno fatto loro prendere. Se dovessi dire da dove mi derivano le influenze maggiori, direi dalla pittura – prima fra tutte – e dalla musica, e con questa intendo proprio la sola musica, non le parole che possono eventualmente starci insieme. E magari anche qualche atmosfera respirata nelle inquietanti serie televisive che arrivavano dalla Gran Bretagna o dalla Svezia alla fine degli anni Settanta. Ma la pittura su tutte, sì. Ho un rapporto con quella che è molto simile a quello che ho con la parola e le lingue in generale: sono mondi dentro i quali camminerei per ore senza mai stancarmi. Un po’ sinestesico come concetto, ma trovo molta più ispirazione in qualche folgorante velluto verde di Rogier van der Weyden, in alcuni sguardi di Hugo van der Goes, negli emozionanti scorci della campagna veneta all’imbrunire alle spalle di qualche personaggio di Sebastiano del Piombo piuttosto che in tante parole. Come poi in alcuni casi la pittura si faccia parola, credo sia una questione di chimica sulla quale non mi interrogo. Poi, certo, mi ispira fortissimamente anche la geografia sonora che risvegliano in me le diverse lingue alle quali mi accosto. Forse è questo a creare musiche insolite per alcuni lettori, non so.
– Definisci il tuo stile poetico con un aggettivo e spiegane il motivo.
Non saprei. Faccio fatica a mettermi dentro una cornice. Definire significa anche escludere, e chissà che non mi capiti di lasciare fuori qualcosa di fondamentale. “Collaterale”, forse? Una scrittura dell’imbrunire e dell’albeggiare? No, proprio non saprei.
– Tutti i poeti hanno delle parole, delle frasi che non riescono a fare a meno di usare. Quali sono le tue parole o frasi più ricorrenti?
Quello che non riesco a fare a meno di fare è scrivere. Punto. Ma posso anche astenermi per lunghi periodi, se i tempi non sono maturi. Frasi o parole che non ce la faccio a non usare? Quelle all’interno delle quali non risuoni la musica inquietante del nostro precario equilibrio tra la vita e quello che di questa avremmo voluto o vorremmo fare. Ecco. Mi è stato fatto notare che in molti miei scritti ci sono tempo, memoria, ma soprattutto luoghi. Che per me sono la mappatura dell’esistenza.
– Si dice che per vedere il mondo per quello che è veramente si dovrebbero guardare commedianti, artisti e poeti. Che cosa pensi emerga spontaneamente dalle tue opere?
Non so cosa e come il mondo sia davvero. E quale mondo, poi? Per quel che mi riguarda, di mondi ce ne sono quotidianamente centinaia di migliaia, diversissimi tra loro e spesso in rotta di collisione l’uno con l’altro. Certo, le persone che citi hanno forse in buona parte l’incapacità di venire a patti con ciò che tantissimi altri si fanno andar bene presto e in fretta, sono animate dalla necessità di non transitare mai troppo lontane dal nucleo che costituisce la propria architettura personale, ma anche da uno stato primordiale dell’esistenza, dall’essenziale, che dovrebbe essere quello di godere dello splendido spettacolo che questa può offrire se solo si è disposti a coglierlo. Ma il mondo è purtroppo anche altro, e non si può disconoscerlo. Quando scrivo, la vita si fa più intensa e percussiva, e vibra attraverso le parole. Ogni singola riga, ogni singolo verso ripropongono questo: il vero peccato originale è il farsi passare la vita sopra la testa senza coglierne lo stupore o la bellezza degli incontri. Con le persone. Con i luoghi.
– Spesso i poeti sono attivi anche in altri campi creativi. Oltre alla poesia ti esprimi anche in altri campi artistici non-letterari? Quali?
Da ragazzo pensavo che sarei diventato un pittore. Mentre i miei compagni di classe si vedevano proiettati in professioni molto meglio remunerate e sicuramente più prestigiose, io volevo solo continuare a sentire l’odore dell’olio di lino e a vedere il colore delle tempere e degli olii che usciva dai tubetti. Quelle belle tele bianche su cui passavo le dita accarezzandole, e le tavole levigate che trovavo sugli scogli di Pellestrina o sulla spiaggia di Sottomarina… E poi i nomi di quei colori, i nomi…! Roba da andare fuori di testa. E contemporaneamente adoravo la musica, mi cimentavo con più di uno strumento. Che tristezza constatare all’inizio dell’adolescenza che non si potevano scegliere contemporaneamente due, tre o quattro vite! Che trauma sapersi limitati a scelte che avrebbero circoscritto sempre di più le mie strade così come quelle di tutti gli altri. Credo sia quello l’Eden perduto a cui tutti guardiamo e che cerchiamo di ricostruire o perlomeno di ritrovare, quel paradiso luminoso che è rimasto intatto nei nostri primi anni di vita. Un po’ quello che accade ne Il Forte San Felice di Fossa Clodia… Ho poi ripreso a dipingere più o meno una decina d’anni fa, ma ho subito smesso. Chissà, forse un giorno potrei riprendere.
Mi piacciono tantissimo le collaborazioni, per cui mi capita spesso di mettere il naso in territori per me quasi vergini: ci sono ad esempio artisti che hanno musicato dei miei testi – i Maieutica con il loro rock progressivo e Daniele Bertoldin con la sua modernissima lirica sperimentale – e questo ha fatto sì che io abbia potuto frequentare, anche se per periodi circoscritti, quei mondi. Alcune mie cose hanno quindi subito delle metamorfosi, ma non per mano mia. Poi ho collaborato con fotografi e registi teatrali, e ho in cantiere una collaborazione con un poliedrico pittore dall’ingegno proteiforme. Ecco, sì: la fotografia è un campo che frequento con grande assiduità. Quello sì. Mi piacerebbe se un giorno ci fosse la possibilità di pubblicare un lavoro in cui compaiano delle mie fotografie. In parte questo è già avvenuto con Fossa Clodia (2015) e Lingua Madre (2017), ma vorrei fare delle immagini una presenza forte, costante sulla pagina, di cui le parole dovrebbero essere una compagnia discreta e quasi silenziosa. Una specie di haibun sui generis: la foto come testo in prosa, e la parola come haiku di suggello e trampolino.
– Quale tipo di letture preferisci?
Su tutte, i manuali per imparare una lingua straniera. A rotazione, qualsiasi cosa – davvero qualsiasi – sia scritta in una lingua che mi abbia stregato, fossero anche le pagine di un dizionario. Mi perderei per ore a guardare la bellezza dei segni combinati in modi del tutto inattesi per il mio occhio o il mio orecchio. Mi verrebbe da dirti che sono un lettore onnivoro, ma direi una grande bugia, perché è sì vero che leggo molte cose diverse, ma queste sono pur sempre in qualche modo legate tra loro e ne escludono molte altre: ecco così gli storici bizantini, la poesia cinese classica, gli haijin giapponesi e non, gli specialisti di afrikaans e le loro indagini linguistiche, la letteratura neogreca e portoghese contemporanee, ma anche la poesia tedesca del Novecento e alcuni narratori dell’Est Europa, i resoconti dei viaggiatori medievali… quante meraviglie! E quante non riuscirò mai a sapere che esistono, ahimè.
– In tempi recenti è sempre più frequente la pubblicazione di poesie su blog o social network. Molto spesso si possono trovare lavori interessanti e ben scritti. C’è qualche poeta che torni a leggere di frequente e che vorresti raccomandare?
I mondo dei blog e dei blogger è per me ancora un territorio del tutto inesplorato. Per quanto riguarda la rete in generale, poi, è vero che c’è molto di interessante, ma è altrettanto constatabile come ci sia anche tanto plagio, e l’autoreferenzialità di internet è il rovescio della medaglia del sacrosanto diritto che ciascuno di noi ha di far conoscere le proprie cose. Per cui va accettata, fa parte del gioco. Difficile comunque che io legga di frequente sempre gli stessi autori. Mi attraggono alcuni gruppi, ma sono nel contempo spaventato dall’integralismo di alcuni, che finiscono per diventare ai miei occhi adepti di una setta esclusiva con cui sento di avere poco in comune. Mi sento semplicemente fuori posto quando mi viene chiesto di guardare sempre nella stessa direzione: magari alle mie spalle mi sto perdendo qualcosa di splendido… E poi perché non godere di tutta la vista attorno a me?
– Hai mai pubblicato una raccolta personale delle tue poesie? Se sì, fanne una breve descrizione indicando anche i dettagli della pubblicazione (editore, distributore).
Ho pubblicato raccolte di poesia (Foreste sensoriali nel 1993; Lettere dal mattatoio e La pergamena delle mutazioni nel 2002; la silloge bilingue in italiano e neogreco Sedici settimane | Dekaxi vdomades in collaborazione con la poetessa greca Keti Màraka, nel 2007; la raccolta bilingue in italiano e neogreco Suites in collaborazione con Keti Màraka nel 2008), tra cui anche tre raccolte di haiku scritti in italiano e latino classico (Piscine nel 2007, Oz nel 2008 e Tundra nel 2009); i libri di prose brevi (prose poetiche? scritture polimorfiche?) Cronache dal centro della notte nel 2004; Tutti senza nome nel 2006; Il canone del tè nel 2007, ripubblicato ampliato, una volta esaurito, nel 2013; Dei vizi e delle virtù nel 2010; Neve nel 2011; Cartoline da Trapani nel 2013. È poi stata la volta della sperimentazione con il dialetto, la forma teatrale e una scrittura “a tasselli” con Fossa Clodia nel 2015, e ancor più con Lingua Madre nel 2017. Nel 2007 è uscito anche un libriccino scritto interamente in inglese, Plays, nel quale ho tradotto e adattato testi di Tutti senza nome e di Lettere dal mattatoio. Sono perlopiù queste ultime le cose che ho portato all’estero, a festival o ad eventi culturali che hanno visto coinvolti artisti provenienti da discipline diverse – soprattutto in Finlandia e Svezia. Negli ultimi anni, poi, ho avuto l’onore di ricevere l’invito a presentare alcuni miei lavori all’interno della rivista fondata e diretta da Stefano d’Andrea Le Lumachine – Foglio degli amici dello haiku. Stefano ha il grandissimo merito, tra le altre cose, di avermi continuamente stimolato e spronato a sperimentare ancora la forma haiku dopo una lunga pausa che mi ero preso dalla presentazione al pubblico di un genere che per moltissimi è, ahimè, ancora poco comprensibile e troppo sottovalutato. Ricordo ancora un critico che, qualche anno fa, disse: “La moda dell’haiku ha preso piede per ovvi motivi, tra cui la sintesi, com’è richiesto dall’attuale poetica”. Ecco, se persino gli addetti ai lavori dimostrano questo tipo di pregiudizi – moda? ovvi motivi? – c’è il rischio che questa forma poetica diventi o dilettantismo o, al contrario, il credo di qualche setta dalle velleità esclusiviste. Io da parte mia ho continuato a scrivere haiku, ma tenendoli semplicemente per me. E Stefano d’Andrea mi ha stanato. Il merito è tutto suo.
Oltre alle piattaforme già citate, opere mie o selezioni di quelle sono comparse su riviste italiane e non (Poesia, Corrente Alternata, Il Foglio Volante, Litteratura, Mosaicul, La Nuova Tribuna Letteraria), mentre una parte è stata ospitata in rete in formato digitale (farapoesia, narrabilando, literary.it e, appunto, le deliziose Lumachine).
Informazioni sul contenuto, l’editore e la reperibilità di questi testi – molti dei quali, eccetto Suites, sono stati ormai riversati anche in formato digitale e pubblicati in versioni riviste, corrette e a volte integrate – si possono trovare sul mio sito internet.
– Spesso i poeti sono persone eccentriche. C’è qualcosa di te che rientri in questa definizione?
Una volta sono stato definito eccentrico nel senso etimologico del termine, ovvero lontano dal centro, come un pianeta o un satellite che descriva attorno ad un altro corpo celeste un’orbita in grado di portarlo a tratti anche molto lontano da quello. Si stava parlando quella specifica volta dei comportamenti – ma soprattutto delle scelte – che fanno di un autore uno scrittore mainstream o perlomeno un candidato tale. Ecco, a questo riguardo le mie sono sempre state scelte squalificanti da un punto di vista commerciale: ho cominciato con la poesia, che è già, fra tutti i generi, il meno appetibile per il palato del grande pubblico; a complicare la mia imbarazzante posizione ho poi proseguito restringendo ulteriormente il campo con gli haiku, di cui all’epoca pochissimi – se non gli specialisti – sapevano e di cui ancora meno dimostravano di apprezzare la delicatissima architettura; quindi, se potevo far di peggio, l’ho fatto: in un momento in cui calciatori e gente dello spettacolo compongono – o si fanno comporre – le proprie memorie e queste vanno letteralmente a ruba, sono passato a scrivere in un genere che pochi hanno dimostrato di saper definire per quello che è, cioè scrittura totale punto e basta, ma anzi ha destato in alcuni imbarazzo e in pochissimi altri – fortunatamente ci sono stati – grande interesse. E siccome si può sempre complicare la situazione, eccomi approdato da qualche anno alla scrittura sperimentale in dialetto e italiano, a dimostrazione che la lingua è una e molteplice allo stesso tempo. Ma a chi può interessare? Quando ho potuto scegliere di far tradurre alcuni miei testi in altre lingue, poi, ho deliberatamente cercato il contatto con realtà linguistiche marginali o marginalizzate o comunque di difficile collocazione nel panorama internazionale – Svizzera romancia, isole Shetland, Frisia, l’esperanto, tanto per dirne alcune. Insomma: più eccentrico di così… Sotto quest’ottica, merita quindi un plauso la prof.ssa Francesca Rossi che, nel 2015, ha reso la mia intera produzione letteraria edita fino a Cartoline da Trapani oggetto di una Tesi di Laurea Magistrale all’Università Ca’ Foscari di Venezia ma, ancor più di lei, il prof. Alberto Zava, coraggiosissimo docente che le ha permesso di dissertare su un perfetto sconosciuto ben lontano dal crisma dell’ufficialità e che io ho avuto il piacere di conoscere il giorno in cui Francesca si è laureata.
– Per chiudere l’intervista cita tre dei tuoi versi che credi siano i migliori (indicando tra parentesi il titolo della poesia e, se pubblicata, dove leggerla).
la vita che conosciamo è solita spiegarsi solo d’inverno, quando sembra un’impronta sulla superficie e il lago è gelato. talvolta capita, però, che in alcuni punti il ghiaccio sia più sottile che altrove. e d’improvviso capiamo che la verità sta sul fondo.
Tutto in minuscolo, sì. Non sono tre versi, e forse commetto una grave ingiustizia nel non dare voce ad altri, ma quello che mi viene subito in mente è questo, da Tutti senza nome. Credo rappresenti bene ciò che è in questo momento la mia scrittura. Il resto, se mai arriverò un giorno a pubblicarlo, mi candiderà a farmi tirare dietro i sassi.
Fonte: