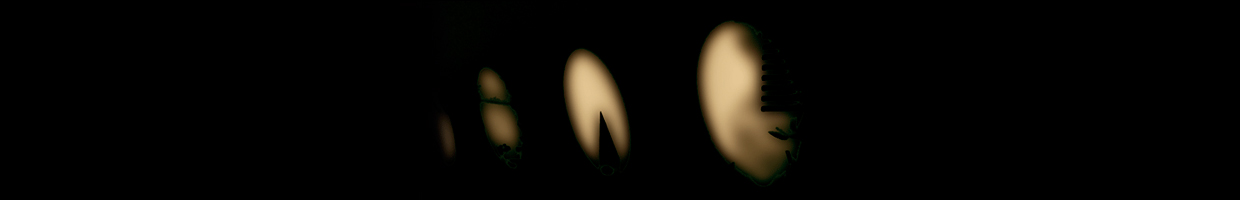La Nuova Tribuna Letteraria, Anno XXVIII n. 129 (1° Trimestre 2018)
Le parole nell’acqua
La rivalsa del dialetto nel libro di Renzo Cremona
di Stefano Valentini
Chi conosce l’opera di Renzo Cremona sa come, tra i temi più ricorrenti nella sua bibliografia, vi siano quelli dei luoghi e del linguaggio. Questo ultimo, corposo volume (330 pagine, sia pure in parte dovute al testo a fronte che accompagna le pagine in dialetto veneziano di Chioggia), dall’impianto originale e irriducibile ad un genere, si fonda sull’intreccio di entrambi: spazio natio fisico e, ad esso connaturato, spazio delle parole. La prima parte consiste in un lungo dialogo surreale e via via più acceso, a due sole voci personificate, tra la lingua italiana – espressione dell’ufficialità, della legge, delle procedure, della burocrazia – e il dialetto chioggiotto ridotto al ruolo di turista, costretto a chiedere un visto per accedere a quella che sarebbe la sua casa. Un confronto vivace, dove il dialetto è costretto a ribadire all’interlocutore il proprio diritto ad esistere, la propria autonomia e persino ricchezza rispetto alla lingua dominante, tra osservazioni pungenti e ironie cui l’italiano sa rispondere soltanto sulla base delle “regole”. “Un dialetto è una lingua lo stesso, una lingua a cui hanno tolto il pane di bocca” afferma il chioggiotto “non è che di per sé non sia in grado di esprimere determinati concetti, è che non glielo fanno fare”. Una discussione che si allarga alle differenti lingue e che, di polemica in polemica, sfocia negli esempi che il personaggio-dialetto porta: brani tradotti in chioggiotto di Platone e Ritsos, Leonardo, Brecht e Petronio. “Quando vuoi far sparire qualcuno o qualcosa, il miglior modo per farlo è quello di non parlarne più”, accusa. La sua non è una rivendicazione “contro” l’italiano, di cui riconosce i meriti e la necessità, bensì “voglio solo che in casa mia non mi facciano stare seduto al posto dei disgraziati”. Il lungo colloquio non dirime la questione, non può: “manca il filo per ricucire insieme le pezze di quel che siamo stati detti”. Il corpo successivo del volume somiglia ad un romanzo per quadri o frammenti, intrecciati fra loro e tutti narrati in prima persona, chi in italiano chi in dialetto, e la presenza o meno del “testo a fronte” sembra elemento metatestuale a propria volta. Cremona costruisce un’affascinante allegoria nella quale s’intersecano un cane smarrito, medici e pazienti, guide tra reperti storico-artistici, chiromanti che tentano di decifrare incubi e sogni, dottori alle prese con misteriosi tagli e sanguinamenti, farmacisti e ricette, preti e psicologi. Il tutto mentre una fittissima nebbia scende sulla città, impedendo tanto l’arrivo che la partenza ai mezzi e alle auto, e il reflusso delle acque blocca le imbarcazioni, lasciandole in secca nell’impenetrabile caligine: è “il bianco insondabile del nulla, la privazione incomprensibile del senso”. Sicché “venne così il giorno in cui la città ridiventò isola”, sperimentando “il dissiparsi fitto e compatto di significato su un molo orfano di attracchi”. Nel frattempo, in questa ovattata irrealtà, “i luoghi si svegliano” e le parole del dialetto tornano a manifestarsi, dapprima a scuola poi nelle stesse voci delle persone; anche gli ambienti mutano, sugli scaffali di un supermercato si rivedono prodotti di sessant’anni fa, vecchi negozi scomparsi riprendono il loro posto, telefonate arrivano da numeri non più attivi o intestati a persone morte. Morti che, addirittura, riappaiono nelle foto, accanto ai vivi. Finché entra in scena il Tempo, “io che ad alcuni piaccio e che tutti metto alla prova”, fiero e sprezzante nel suo potere “essendomi concesso di ribaltare una legge e anche l’altra, e in un solo attimo da me partorito piantare e togliere usanze”, e dopo il Tempo entra “lui”, “Elo”, che ha provocato tutte queste stranezze, che ha fatto “svegliare le parole”, quelle parole che “ci sono, si devono solo cercare”. Elo, il dialetto, che in un lungo monologo riafferma se stesso, le sue ragioni, la sua esistenza, in una maestosa recriminazione-perorazione sul valore della lingua-madre come identità, fondamento e nominazione del mondo, con la minaccia-maledizione a “stare bene attenti”, poiché “dopo di me non resterà più nulla”. Un intermezzo di cantilene, queste soltanto in dialetto e senza traduzione a fronte, introduce l’ingresso della Fine: “cosa sono quelle cose che vengono a galla?”. “C’erano, eccome se c’erano, bisognava solo cercarle”. Le parole, nell’acqua che torna, nel diluvio. Renzo Cremona ci consegna un’opera di strepitosa suggestione sul tema del dire, del comunicare, del comprendere, che in ultima occasione coincide con la suprema necessità della condizione umana: sapere, fin dove possibile, da dove si viene e dove si va.