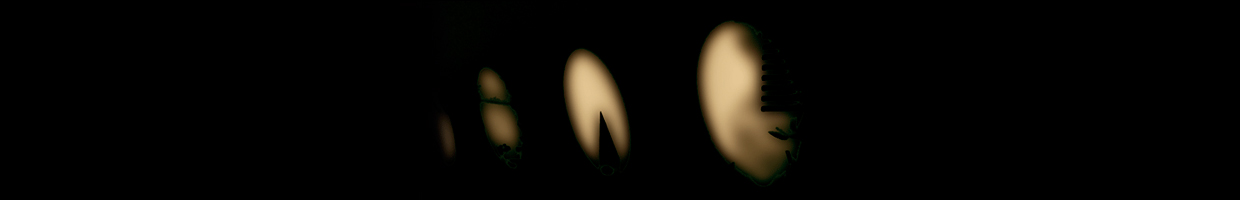La Nuova Tribuna Letteraria, Anno XXVI n. 123
Renzo Cremona, Fossa Clodia
di Stefano Valentini
Le “quaranta brevi storie di terra e di acqua”, in italiano o in dialetto di Chioggia (con traduzione, ma non sempre), che costituiscono questa raccolta sono, come accade in molti dei libri di Cremona, di genere indefinito tra la poesia e la narrazione: la si potrebbe dire poesia in prosa, per l’intensità e la densità, se non fosse che anche questa è una definizione, come tale quindi imprecisa. Perché lo stile riflette l’intento e, di sicuro, questo libro non ha tra i suoi scopi quello di definire, semmai il contrario: in-definire, sfocare i contorni, abbracciare l’insieme (il senso dell’insieme) più che il singolo dettaglio. Diciamo allora che sono, appunto e semplicemente, “quaranta brevi storie”, alcune di più pagine e altre di poche righe. Storie i cui protagonisti non sono l’io narrante, che tiene saldo per sé il ruolo dell’osservatore, e neppure le figure umane che pure in alcune compaiono bensì, come già in precedenza e altrove, i luoghi e le strade, l’orizzonte e l’illimite: la “Fossa Clodia” del titolo, nome antico di Chioggia, è un po’ tutto questo, luogo di non ben decifrabile separazione tra terraferma e laguna. Il tempo, abbiamo detto, “corrugato eppure intento a non far grinze per paura di tradirsi”, il tempo che “non si capiva dove affluisse alla vista, perché giungeva complesso e ripiegato, a strati, fino a diventare spesso e colloso”, e questo è un tempo solido che già si fa destino. E abbiamo detto luoghi e strade, soprattutto, che prendono la parola come entità vive. Parlano le vie, come la canaletta del Perottolo aperta e richiusa, parlano le cose, come la forcola intagliata da un olmo cui è toccata “la sventura della rarità”. Quanto a noi, abitanti o spettatori, leggiamo un frammento: “in forma non dissimile da quella di un vivaio sospeso sull’acqua stanno i nostri giorni a meravigliarsi della vita che passa”, osservazione neppure troppo originale tra le molte invece geniali, ma di grande eleganza come elegante è l’intero libro. Si noti lo scarto: non siamo noi a meravigliarci della vita che passa, ma i nostri giorni, secondo un processo che sposta l’interno all’esterno, l’individuale al collettivo. Perché quel “nostri” può esser sì un plurale maiestatico, ma più probabilmente è un plurale e basta, è davvero un “noi”. Dove anche il “noi”, però, è qualcosa d’altro, perché Cremona esplora la singolarità come “misdirection” per alludere all’insieme nel quale nulla è inutile e nulla è indispensabile, in uno sguardo che è al contempo nitido e impreciso, esplorazione e abbraccio. Sembra quasi che ogni cosa abbia una sua rotta, anche quelle immobili, e in effetti è così, perché anche l’immobilità è un destino: tra acqua e barene ci si muove non autonomamente, ma assieme a tutto il resto, e non nello spazio ma nel tempo. Così come, per quanto attiene alle parole, ci si ritrova incerti, o magari certissimi, tra “monosillabi desiderosi di lambire la tenerezza” e “alfabeti che si erano creduti dimenticati”. A compulsarlo riga per riga, un libro come questo, palesemente figlio dell’evidentissimo amore che l’autore nutre per i propri luoghi, si potrebbero elencarne cento e cento, di motivi ed osservazioni, perché infine le storie sono anche, per l’appunto, storie: ma si rischierebbe di far coincidere la mappa con il territorio, come diceva Borges, e dunque qui ci fermiamo, ma soltanto per oggi.