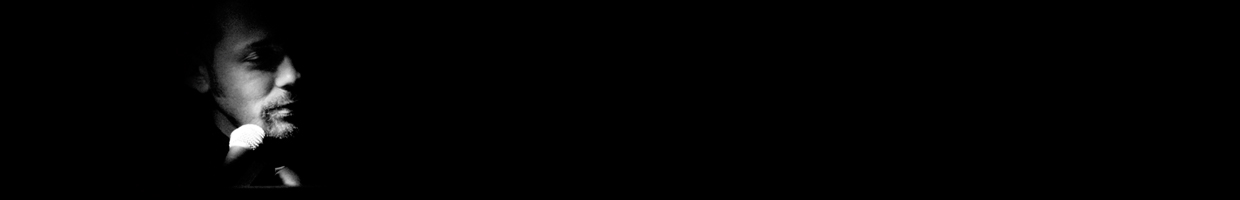Renzo Cremona: Fossa Clodia e la prosa poetica della marea
di Giulia Zandonadi
– Mi parli del titolo del suo libro, “Fossa Clodia”: si tratta di un riferimento classico a Plinio il Vecchio il quale, nella sua Historia Naturalis, parla appunto di “Fossa Clodia” e “Brundulum”. Inoltre, Clodio, reduce dalla distruzione di Troia, insieme ai compagni Enea, Antenore e Aquilio sarebbe approdato nella penisola italica ed avrebbe fondato Clodia. Cosa l’ha spinta a partire da queste origini mitiche? Ce le può raccontare? Quale messaggio voleva veicolare attraverso questa scelta?
Il titolo, Fossa Clodia, è costituito da due strati differenti ma comunicanti. Il primo, quello che emerge in superficie, fa riferimento al nome romano dell’area di Chioggia, ma non risponde al semplice desiderio di rispolverare una toponomastica dell’arcaico per dare una patina di antico alla narrazione; si tratta invece di una precisa volontà di andare alle origini, alle mie origini, ai luoghi in cui sono nato, cresciuto e vissuto, e allo stesso tempo all’origine di questi luoghi, all’origine delle origini: ecco perché il primo nome, anzi, il nome primo della città. Il secondo strato, quello che giace in profondità, punta il dito alla “fossa” che qualsiasi luogo diventa o rischia di diventare se rinchiuso troppo a lungo in sé stesso, involuto e ripiegato verso l’interno, diffidente e refrattario alla malleabilità: un rischio sempre dietro l’angolo con le piccole e grandi isole. Tuttavia, la specificità che contraddistingue i luoghi insulari può – se impiegata come risorsa e non come catenaccio – magicamente trasformarsi nel loro punto di forza, perché li aiuta a preservarne le peculiarità.
– Lei ha studiato neogreco, cinese, portoghese e georgiano: quanto ha influito tutto questo nella sua produzione letteraria e in particolare su questo libro?
È stato scritto che “abito la lingua”. Credo che questa definizione mi inquadri sufficientemente bene. Studio lingue fin da piccolissimo, e mi occupo di traduzione e di insegnamento di lingue da molti anni. Alcuni tra i primi ricordi della mia vita hanno proprio a che fare con suoni, segni, parole, geografie mentali che le lingue producevano già negli anni della mia infanzia. Qualche critico ha affermato che la conoscenza e lo studio delle lingue dona alla mia scrittura una particolarissima musicalità. Io sono più propenso a pensare che il mio atteggiamento nei confronti della lingua si sia invece diramato in due direzioni complementari le quali, più che influenzarsi a vicenda (com’è del resto inevitabile quando ci occupiamo di più cose nello stesso momento), sono in effetti due manifestazioni coesistenti di tale atteggiamento unitario di fondo: la visione della lingua come mondo da esplorare e percorrere secondo le stesse modalità di un cartografo meravigliato dell’esistente intento a mappare le sue continue scoperte. A dieci anni tracciavo isoglosse immaginarie che popolavano i campi davanti alla finestra di casa o percorrevano gli scogli del Forte San Felice. Come tutti i libri che l’hanno preceduto, anche Fossa Clodia è il frutto di questo peregrinare semirandagio tra le parole, la tradizione e la sperimentazione. Anzi, credo che al momento Fossa Clodia sia quello che più di tutti tra i miei editi mette in scena la sperimentazione linguistica: si trattava di creare un linguaggio vernacolare che non tradisse i suoi tratti fondamentali (doveva, cioè, risultare “reale” e perciò traducibile in parola parlata) ma allo stesso tempo uscisse dalla dimensione folcloristica in cui spesso il dialetto è stato relegato. Dimensione assolutamente rispettabile e nobile, benintesi: ma io ho voluto lavorare la materia linguistica per renderla elastica e piegarla a moduli espressivi nuovi. Ed è risultato evidente come in dialetto si possa scrivere non solo di prosa e poesia (come è stato fatto del resto per secoli), bensì anche di filosofia; come, inoltre, si possa tradurre Kavafis o mettere in scena uno stream of consciousness o addirittura creare una rielaborazione di nonsense medievali.
– “Fossa Clodia”: poesia o prosa, secondo l’autore? Anche la scelta della punteggiatura e del ritmico modo di procedere ricordano l’andamento della marea: ci parli di questa impostazione stilistica.
Sono quasi quindici anni che questo problema si pone. O meglio, che questo problema mi viene posto. Quando, con Cronache dal centro della notte e poi con Tutti senza nome ho cominciato a mettere nero su bianco quello che è il mio personale modo di vivere la scrittura, si è subito creato attorno a me un certo imbarazzo: prosa o poesia? Chiariamo: questo imbarazzo ha sempre riguardato più le giurie dei premi letterari che i lettori, essendo quelle costrette a collocare le mie opere nell’una o nell’altra categoria. Ma tali collocazioni rispondono solo al nostro bisogno tutto culturale di mettere delle etichette: non è un caso, infatti, che non di rado gli stessi titoli siano stati classificati in modo diametralmente opposto o abbiano ricevuto riconoscimenti in sezioni diverse a seconda delle commissioni giudicatrici. La scrittura è una, unica e indivisibile, così com’è una, unica e indivisibile, pur se continuamente rifratta e moltiplicata, l’esistenza in cui ci muoviamo e di cui siamo fatti: è il verso a creare la poesia e la sua assenza a convertire il testo in prosa come per sortilegio? Oppure è una sottilissima e quasi impalpabile musicalità della parola, un suo utilizzo chiaroscurale, l’intrecciarsi di stratificazioni e l’indefinibile inquietudine di cui è animata a fare di una pagina un pezzo di poesia? E poi ancora: dove sta scritto che poesia e prosa non siano in alcuni momenti talmente frammiste l’una all’altra da non essere più rintracciabili come elementi distinti, bensì come volti opalescenti di un unico corpo illuminato da raggi provenienti da direzioni di volta in volta diverse? In fin dei conti, non è così appunto anche la nostra vita? Prosa e poesia convivono senza disarmonia. In questo non ci vedo una creatura-mostro, né ravviso quell’universo nebuloso “né carne né pesce” con cui alcuni cercano di parlare di scritture che esulino dai generi tradizionali. Tradizionali per chi, poi? mi verrebbe da dire. In alcuni Paesi del mondo (l’area nord-americana, tanto per dirne una, ma anche quella neogreca o portoghese o tutta la letteratura classica cinese) si parla da decenni (o da secoli) di prosa poetica. Ecco, io definirei le mie semplicemente “scritture”, o meglio, “itineranze della parola”. Per questo sono stato felicissimo che l’editore abbia deciso di collocare Fossa Clodia in una collana che si intitola proprio “Scritture”.
Quanto alla punteggiatura, la seguo in maniera maniacale. La maiuscola, come ebbe modo di dire anni fa Alvise Foschi nella postfazione di Tutti senza nome, manca non per una finta posa da pseudo-avanguardista, bensì perché le pause e tutte le forme di gestione del ritmo e del tempo nel linguaggio si sentono (oltre che vedersi), mentre le maiuscole no. Un numero spropositato di lingue del mondo, aggiungo io, non ne fa uso e vive benissimo; certo, metterle a volte fa un servizio al lettore, ma quando parliamo ne abbiamo forse bisogno? Abbiamo invece bisogno della punteggiatura, di quella sì, perché segnala l’evoluzione del pensiero. In Fossa Clodia proseguo la tendenza di Neve e Cartoline da Trapani, in cui è la parola stessa a plasmare il mondo che descrive, non il contrario (in Neve questa tendenza era particolarmente pronunciata, ad esempio). Per cui, certo, c’è l’andirivieni delle maree che ciclicamente assediano Chioggia, ma anche il movimento di costante avvicinamento e allontanamento da luoghi con i quali la convivenza non è stata sempre facile.
– Cosa l’ha spinta a parlare di Chioggia, sua città natale?
Quattro anni fa, nel settembre del 2011, partecipai alla III Edizione del Premio Letterario Città di Chioggia con una raccolta di otto storie intitolata Fossa Clodia: c’era in nuce quello che poi, con il tempo, si sarebbe sviluppato fino a diventare l’attuale libro. All’epoca stavo ancora scrivendo Cartoline da Trapani, dedicato ad una città alla quale sono particolarmente legato, e l’idea di raccontare la “mia versione dei fatti”, anzi, la “mia versione dei luoghi e dei tempi” di Chioggia mi attirava. La città si ritraeva, tuttavia, come se non volesse essere descritta o raccontata, quasi si perdesse nelle sue celeberrime nebbie e tra le acque alte. Ho lasciato quindi che i tempi maturassero. Poi è venuta un’estate fatta di studi lunghi, lunghissimi, ma studi appassionanti e rivelatori: documenti, ricerche, esplorazioni e continui avanti e indietro fra la parola antica e quella moderna; ho rispolverato i miei vecchi libri di e in chioggiotto, ho messo a fuoco le prime storie in vernacolo. Le ho ascoltate, le ho lette a voce alta, ho cercato di coglierne le ripercussioni più profonde e sono rimasto a guardarle crescere sotto i miei occhi, mentre lavoravo come un artigiano la materia linguistica giorno e notte senza interruzione. Poi lasciavo che la pasta lievitasse e tornavo a lavorarla. E così è stato che mi si è dischiusa una porta che non avrei mai pensato di aprire. La scrittura in chioggiotto.
– Alcuni punti mi hanno colpita molto: in particolare, potrebbe parlarci della figura del fotografo che compare ricorrente nel corso dei vari racconti?
Il fotografo, o meglio el somegèro, è il personaggio-cardine di quella che è stata già definita una Spoon River clodiense: non compare mai in alcuna pagina eppure è presente in ogni singolo pezzo di questa particolare sezione. Ma mentre nella Spoon River americana sono le lapidi di un cimitero a raccontare la propria storia, in queste pagine sono invece le fotografie scattate in un tempo ormai uscito da quello delle umane vicende a mettere a fuoco episodi di esistenze finite nel dimenticatoio, offuscate, frantumate, quasi appassite. Sono le voci delle marginalità cittadine, quelle che non possono che essere raccontate nella lingua di cui sono fatte, resistenti alla traduzione, renitenti a qualsiasi forma di conversione e trasposizione. Trovo commovente il desiderio dell’uomo di voler rimanere, di dichiarare la sua presenza qui e adesso facendosi immortalare in una fotografia, la sua (la nostra) paura che nulla rimanga di tutto quello che ha arredato la nostra esistenza. Ecco perché le foto e il fotografo. Ma anche le foto ingialliscono. E la parola, l’unica rimasta, anche lei sull’orlo dell’estinzione, cerca di farsi testimone di questa irrefrenabile e smaniosa erosione del tempo.
– Per tornare sul tema del mito, lei inizia con l’invocazione alla musa: che tipo di musa è quella a cui lei si rivolge?
Volevo che l’apertura di questa sorta di Telemachia avesse un’intonazione epica per più ragioni: innanzitutto doveva corrispondere alla proiezione in un remoto passato in cui tutto ha avuto inizio, il tempo cioè della Fossa Clodia; in secondo luogo, l’epica racconta le vicende e le lotte attraverso le quali si è costituito quello che è il nostro universo culturale ed esistenziale, quello all’interno del quale si sono coagulati i nostri valori, e Fossa Clodia è colmo di scontri e tentativi di riconciliazione. È un libro di “ritornati”, di uomini e donne che si sono allontanati dalla città e hanno alla fine realizzato che, se non sono stati in grado di fare i conti proprio con la “Fossa”, non saranno mai in grado di lasciarla davvero, perché finiranno per tirarsela dietro dovunque andranno (ecco perché la traduzione de La città di Konstantinos Kavafis, che sembra scritta proprio per Chioggia). È epico, poi, il disperato tentativo di ricostruire i ponti quando in mezzo ci sta l’acqua sempre pronta a risommergerli. Perciò la Musa è allo stesso tempo colei che si invoca per avere la forza di riuscire a portare a compimento l’opera che ci si accinge a narrare, ma anche la parte di noi che riesce ad elevarsi dalle contingenze per riuscire ad avere una visione d’insieme dell’esistenza che trascenda le meschinità del vivere quotidiano: è a quest’ultima che bisogna rivolgere preghiere per non affondare nelle melme dei compromessi delle abitudini.
– Parliamo del dialogo finale, “Le parole fanno i buchi”: sembra quasi un dialogo platonico, in cui un Socrate-estraneo cerca, con l’arte della maieutica, di far partorire un’idea all’attaccabrighe. Mi sbaglio? E poi mi piacerebbe che approfondisse la questione delle parole che fanno i buchi, che secondo me è un concetto davvero profondo e molto interessante.
Ricordo che da ragazzino, una volta, mi capitò di sentire questa frase dalla madre di un compagno di giochi in riferimento al fatto che, per quanto gravi possano essere o apparirci le cose che ci sono state dette, non saranno e non potranno mai essere pesanti come un pugno in faccia o delle percosse. Non so perché, ma questo modo di dire piuttosto comune mi ha sempre provocato un disagio profondo che non riuscivo esattamente a definire: se le parole non facevano buchi perché, allora, avevano la capacità di causare in me reazioni così violente? E se, poi, le parole non facevano buchi, perché allora le persone le usavano per ferire o colpire il prossimo? A quale scopo?
Quando Fossa Clodia era ormai quasi terminato, è balenata davanti ai miei occhi questa frase che ho sentito ripetutamente durante gli anni d’infanzia (mai, però, in casa mia), e ho pensato che, in verità, la parola può molto; anzi, deve potere molto, la parola deve riacquistare la forza che le è stata progressivamente erosa, se è vero che per salvare il mondo devono essere ormai trovate strade alternative alla prevaricazione fisica come mezzo di risoluzione dei conflitti. Chi, meglio di uno scrittore, doveva difendere la parola? Chi, meglio di uno scrittore, dovrebbe dimostrare che in verità la parola crea, moltiplica, amplifica, estende, distrugge e polverizza il mondo nel quale viviamo?
– Scopro, nei racconti, vere e proprie riflessioni al limite tra il poetico ed il filosofico: qual è il passo a cui è più legato?
Il luogo in cui tutto torna, il luogo al quale tutto ritorna, è il Forte San Felice, quello che ha plasmato il mio mito personale. Il Forte è il punto nevralgico a cui tutto il libro tende come ad un polo magnetico, a cui inesorabilmente ci si avvicina mentre attorno il giorno si spegne e ci si approssima alla notte. Come diceva Pavese, i miti sono quelle immagini del mondo che si sono create nel nostro passato arcaico alle quali costantemente facciamo riferimento e che sono diventate per noi, vorrei aggiungere, il codice di decrittazione dell’intera vita. Ma se dovessi indicare altri passi, c’è senz’altro la metamorfosi di uno degli stravedamènti minori a chiedere di essere citata: un uomo sente improvvisamente dell’odore di pane venire dalle tegole che ha nel cervello e si ritrova all’improvviso un friabile bossolà; non fa in tempo a rendersene conto che finisce mangiato. Ecco, la sua filosofia è tutta qua: meglio finire a morsi che ammuffiti, come se cercasse fino all’ultimo un contatto – per quanto divoratore e definitivo – con questa città che gli si sottrae di continuo, piuttosto che essere lasciato a marcire nell’indifferenza.
– Tra i miei preferiti c’è “Vieri”: “in forma non dissimile da quella di un vivaio sospeso sull’acqua stanno i nostri giorni a meravigliarsi della vita che passa. e attendono, come i granchi, di fare la muta intenerendosi fino a diventare morbidi e quasi incolori per il timore di essere visti, nella certezza che sarà proprio l’essersi fatti cedevoli e molli a guadagnare la loro fine”. Ci potrebbe commentare questo passo?
Per chi arriva a Chioggia da Borgo San Giovanni, cioè dalla terraferma, il ponte che porta in città è costeggiato, sulla sinistra, da numerosi vivai dove vengono tenute le cosiddette moléche, granchi ai quali viene fatta fare la muta e che vengono mangiati quando ancora il carapace è tenerissimo. Ci ho visto una metafora della nostra esistenza: sospesa a mezz’aria (come le ceste nelle quali sono allevati i granchi), fragile ed esposta alle intemperie degli imprevisti, sempre troppo morbida per potere resistere efficacemente a qualsiasi attacco. Ma c’è di più: il senso di meraviglia per i giorni che passano, l’incantamento in cui si cade a farsi dondolare dal fascino ammaliatore di una città come questa, provoca uno smemoramento che potrebbe essere fatale, una sorta di scoglio delle Sirene dal quale non ci si allontana mai più se non a rischio di un naufragio.
– Per quanto riguarda le fotografie presenti nel testo? Cosa può dirci?
Mio padre è un poeta della fotografia. Moltissime sono le immagini che negli anni ha raccolto camminando in lungo e in largo per una città che non l’ha visto nascere (è infatti emiliano) ma lo ha adottato quando ha conosciuto mia madre. Ce ne sono alcune, tra le foto scattate da lui, che ho sempre amato particolarmente. Vedere la città attraverso gli occhi di mio padre è stato un po’ come vedere la genesi di alcuni itinerari che mi assomigliano ma che non sono i miei: è come se in quelle foto fosse tradotto in immagini quello che poi io ho cercato nella parola. Per cui, se un ritorno all’origine doveva essere, che allora così fosse per tutto, anche per la biologia: senza l’incontro tra i miei genitori, due mondi linguistici lontanissimi eppure così vicini, io non sarei mai venuto al mondo.
– Alcuni brani sono in dialetto e accanto presentano il testo in italiano: ha scelto lei di inserire entrambi i testi? Li ha scritti prima in dialetto? Ritiene che il dialetto sia un elemento da mantenere? Riesce meglio ad esprimere determinate circostanze o eventi rispetto all’italiano?
I testi in chioggiotto sono nati in chioggiotto e non sono mai stati pensati in italiano. È stato solo in sede di pubblicazione che ho discusso con l’editore la necessità o meno di mettere un testo a fronte che fosse indicativo di quanto era stato scritto per i non nativi. In origine volevo semplicemente inserire un glossario alla fine del libro come vademecum e traccia di lettura e lasciare il lettore libero di girovagare per queste insolite contrade della lingua; poi, invece, mi è stato fatto notare che questo non avrebbe del tutto risolto i problemi di comprensione dei punti più ardui. Per cui mi sono messo a tradurre tutto quando ormai eravamo agli sgoccioli, con la straniante sensazione di commettere una specie di adulterio: quello che veniva fuori di fianco al testo originario non era affatto il testo originario, ma un mondo che non conservava se non un margine sbiadito di somiglianza con quello di provenienza, un’approssimazione vaga e incerta. Il dialetto è prima di tutto una lingua tellurica, quella con cui viviamo il nostro rapporto diretto con gli affetti, le relazioni, la terra, il nostro essere con gli altri; per me è “lingua madre” nel vero senso della parola: non solo perché mi arriva dalla famiglia di mia madre, ma anche perché è la lingua con cui ho imparato ad esprimere una grossa parte del mio mondo emotivo fin da bambino, il codice con cui l’ho criptato e decrittato, i mattoni con cui ne ho costruito una gran parte. Concordo con chi ha detto che la lingua è un dialetto con un esercito e una marina: è un fatto puramente politico. Chiunque si occupi di lingua ad un livello non dilettantesco sa che non esiste una differenza scientifica tra dialetto e lingua: tutto è lingua. E questo non ha nulla a che fare con separatismi o settarismi di sorta: è un semplice dato di fatto, che piaccia o no. Peccato che spesso sia proprio chi di lingua si occupa a fare per primo delle graduatorie di serie A e serie B in merito ai piani di dignità sui quali collocare i cosiddetti “dialetti” e le cosiddette “lingue”, quando invece il problema è da rintracciare altrove, cioè nell’uso che se ne fa e nelle diverse aree alle quali riserviamo gli uni o le altre.
Come ogni forma linguistica, ritengo quindi che il dialetto (o meglio, la lingua locale) vada mantenuto, perché espressione di una visione della realtà che un altro universo linguistico non può veicolare nella stessa dimensione. In un suo bellissimo libro (Through the Language Glass), Guy Deutscher sostiene che la lingua colora il mondo; io direi che la lingua crea il mondo e lo rende abitabile. All’infinito. E questo è il vero miracolo della parola.
22 ottobre 2015